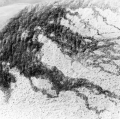MITO E SICILITUDINE – Progetto collettivo LE GRU

MITO E SICILITUDINE
2° Progetto collettivo
Gruppo Fotografico LE GRU
IL RACCONTO DEL MITO
di Alfio BOTTINO (Ideatore Progetto – Socio LE GRU)
Il presente testo è una libera rielaborazione del racconto del Mito greco originario, pensato come testo funzionale di accompagnamento alle immagini realizzate dai soci LE GRU nel Progetto “Mito e Sicilitudine”.
In un tempo lontano lontano in una grande e ricca isola dal nome Creta viveva un potente Re di nome Minosse.
Questi possedeva una grande flotta militare e commerciale per mezzo della quale solcava tutti i mari all’epoca conosciuti facendo di Lui un Talassocrate (dominatore dei mari).
Al fine di preservare dalle tempeste le sue rotte commerciali si preoccupava di ingraziarsi i favori di Poseidone (Dio del mare) operando sacrifici di varia natura.
Un giorno chiese allo stesso Dio di donargli un magnifico toro che avrebbe sacrificato in suo nome. Poseidone acconsentì alla richiesta e gli fece omaggio di un regale Toro bianco; Minosse alla vista del bellissimo Toro pensò di tenerlo per sé convinto che un tale esemplare con mirati piani di accoppiamento avrebbe portato al miglioramento genetico delle sue mandrie e così sacrificò un comune toro nero sostituendolo a quello Divino.
Ma un Dio non può essere ingannato così facilmente ed il Suo Occhio Divino vide tutto lo svolgersi dei fatti e come si dice dalle nostre parti, “Ci unchianu l’occhi” (si arrabbiò tantissimo), scatenando impetuose tempeste e per conseguenza della sua ira inflisse una punizione esemplare al presuntuoso ed irriverente Re Minosse.
Fece innamorare la bella Pasifae (moglie di Minosse) del Toro Bianco, facendo di Minosse il più celebre dei cornuti della storia.
Pasifae mise in campo l’arte della seduzione che con qualsiasi uomo avrebbe dato i suo frutti ma con un Toro tutto sembrava vano, provocando in lei tanta frustrazione e rassegnazione. Disperata ed ormai senza speranza si rivolse al più grande architetto/inventore che la storia antica avesse mai conosciuto, il suo nome era Dedalo.
All’epoca dei fatti, l’architetto, si trovava presso la corte di Minosse al quale rendeva servigi di vario genere in cambio di protezione dagli ateniesi che lo accusavano di aver ucciso, per mera gelosia, il nipote Talo anch’egli architetto e presumibilmente più bravo di lui.
Dedalo di fronte alla richiesta di aiuto della regina di Creta non poté tirarsi indietro: ideò e costruì così uno scafandro di legno a forma di vacca che avrebbe accolto al suo interno Pasifae ed attirato le attenzioni del distratto toro favorendo il tanto desiderato connubio d’amore.
Dall’innaturale incontro amoroso nacque un essere mostruoso, corpo di uomo e testa di toro, che venne chiamato Minotauro.
L’essere mostruoso, una volta cresciuto, si rivelò un flagello per tutta la comunità dell’isola ed un po’ per rabbia per non essere accettato perché orrendo e un po’ per il naturale bisogno di nutrirsi, iniziò a divorare fanciulli e fanciulle. Minosse, preoccupato della sciagura che il suo popolo stava subendo, si rivolse al solito Dedalo affinché trovasse una soluzione che ponesse fine alle stragi.
L’architetto non deluse le aspettative: costruì una prigione che chiamò “Labirinto” dove chiunque fosse entrato non avrebbe mai più trovato la via d’uscita per i tanti vicoli ciechi, per i corridoi tutti uguali e per l’oscurità che avvolgeva ogni cosa. Minosse rinchiuse per sempre il Minotauro al centro di tale labirinto.
Per nutrire l’immonda bestia di carne umana il Re di Creta impose alla città sottomessa di Atene l’invio annuale di 7 fanciulli e 7 fanciulle da dare in pasto al Minotauro. Vani furono i tentativi di fuga delle povere vittime dal labirinto e sangue fu versato lasciando una lunga scia di dolore e morte.
Questi sacrifici si perpetuarono per molti anni fino al giorno in cui l’eroe Teseo, figlio di Egeo re di Atene, si introdusse nell’isola fingendosi vittima sacrificale con il chiaro intento di porre fine alle stragi dei suoi compatrioti. Arianna, figlia di Minosse, perdutamente innamorata dell’Ateniese lo aiutò ad uccidere il Mostro donandogli un gomitolo di filo che gli avrebbe permesso di ritrovare la via d’uscita dal labirinto una volta ucciso il Minotauro. E così fu.
È facile intuire che il famoso filo che Arianna diede a Teseo fu una trovata geniale di Dedalo.
Il fattaccio irritò tantissimo Minosse che non esitò a punire l’architetto ed anche il suo figliolo Icaro rinchiudendoli nel labirinto.
I due prigionieri iniziarono a cercare una via di fuga e quando finalmente la trovarono il grande architetto lasciò prevalere la sua indole di inventore costruendo delle ali con piume di uccelli unite tra loro con cera d’api. Padre e figlio attesero il calare della sera e volarono via in una notte buia rischiarata solo da stelle e comete. Dedalo ed Icaro spiccarono il volo verso la libertà.
Sembrerebbe l’epilogo di una storia a lieto fine, ma così non fu. La tragedia era dietro l’angolo, infatti, malgrado Dedalo avesse raccomandato al figlio prudenza nel volo, questi disubbidì al padre avvicinandosi troppo al sole che con il suo calore sciolse la cera che teneva unite le piume delle ali provocando una rovinosa caduta e morte del giovane.
Dedalo a lungo si disperò e pianse il figlio morto, ma la vita continua e pur di sfuggire dallo spietato Minosse spiccò nuovamente il volo continuando la fuga. Infine, arrivato in vista di un’isola lussureggiante, ormai stanco di volare, vi si posò. Era giunto nelle terre dei Sicani ed il loro Re si chiamava Cocalo.
Negli anni a venire, Dedalo offrì molto a Cocalo costruendo per lui fortezze inespugnabili, terme, prigioni e chi sa quante altre cose che non sono arrivate a noi.
Intanto Minosse, armata la sua potente flotta, salpò da Creta alla caccia dell’architetto. Persi i favori di Poseidone si trovò a dover affrontare mari tempestosi che misero a dura prova uomini e imbarcazioni, giunse infine anch’egli all’isola dei Sicani.
Era la terra dell’abbondanza: non mancava il grano, il sale, l’olio d’oliva, il bitume, il legname e l’acqua dei fiumi scorreva in ogni vallata cosicché l’antica Sicilia divenne terra di conquista per molti popoli provenienti dal mare.
A differenza del Re cretese, Cocalo non possedeva un potente esercito né una grande flotta ma elargì ugualmente all’esercito di Minosse una squisita accoglienza tutta sicana.
Minosse mise in atto uno geniale stratagemma per scovare Dedalo proponendo al Re sicano l’enigma della conchiglia: se Cocalo fosse riuscito a far passare un filo tra le spire di una conchiglia facendolo uscire dall’altra parte avrebbe avuto una ricca ricompensa. Minosse era certo che Dedalo, dovunque fosse stato nascosto, non avrebbe resistito alla provocazione di suggerire la soluzione risolutiva svelando in tal modo la sua presenza.
E le sue aspettative non furono disattese. Dedalo, infatti, suggerì a Cocalo di legare un filo sottile alla zampetta di una formica spingendola poi all’interno della conchiglia finché l’insetto non fosse sbucato fuori dalla parte opposta. Cocalo risolse così l’enigma e Minosse non ci mise molto a capire che dietro vi era l’aiuto di Dedalo. Il fuggitivo fu così trovato e a Minosse non restò altro da fare che chiederne la restituzione.
L’architetto, ormai rassegnato al suo destino di servire il potente di turno, vide che ancora una volta i suoi ingegni gli si rivoltavano contro e sprofondò in uno stato di grande sconforto e disperazione: se per un verso costruiva dall’altro distruggeva.
Anche Cocalo aveva una sua strategia per difendersi dagli attacchi dello straniero: la già citata accoglienza, che in realtà era una falsa accoglienza (il cosiddetto “Mezzo Culo”), consisteva nell’offrire a tutti gli stranieri un’ospitalità disarmante colma di reverenze e premure ma, quando l’ospite ormai rassicurato da tanta gentilezza riponeva le armi, allora veniva mostrato il vero volto ed il suo intento si traduceva nel tenere o nell’eliminare.
Cocalo se da una parte temeva il Talassocrate per la sua potenza, dall’altra non voleva per nulla al mondo rinunciare ai servigi di Dedalo e giocò dunque la sua carta vincente: il celeberrimo “Mezzo Culo” (doppia faccia). Con astuzia ed inganno invitò Minosse a corte fingendo di essere pronto alla consegna di Dedalo; gli rese onori solenni, gli concesse intimità e con l’aiuto delle sue tre figlie lo invitò a fare un bagno in acque rigeneranti. Minosse lusingato da tanto favore cadde nell’insidia ed inebriato dalle calde acque sulfuree trovò la morte affogato dalle tre fanciulle.
Un alone funereo calò allora sull’intero regno.
Per evitare tumulti fra i fedeli uomini di Minosse si fece spargere la voce che si trattò di una morte accidentale e per sostenere tale tesi Cocalo consegnò la salma ai soldati Cretesi, non prima però di aver fatto celebrare solenni funerali ed edificare in suo onore una grandiosa tomba.
Finisce così la storia di potenti Re, di Mogli infedeli, di esseri Mostruosi, di Figli disobbedienti, di Giovani eroi, di giovani Vittime, di Figlie innamorate, di Fanciulle assassine, di Uomini geniali che hanno vissuto e calpestato la nostra terra ma che forse sono ancora qui fra noi e sempre lo saranno.
LA NECESSITÀ DELLA FINZIONE
di Silvano Bicocchi (Direttore DiCult FIAF)
La Mitologia greca riesce ancora a parlarci dopo oltre 2000 anni? A guardare le immagini del progetto fotografico “Mito e Sicilitudine” de “ Le Gru”, sicuramente sì! Ciò accade grazie al formidabile meccanismo narrativo del “Mito” che non si avvale di “c’era una volta” ma di un “altrove divino”, abitato da dèi ed eroi.
Siamo quindi in un contesto separato dalla realtà umana che però con questa condivide storie, appassionati sentimenti, debolezze e virtù. È quindi un confine poroso quello che divide la realtà dal Mito, esattamente come quello esistente tra realtà e Arte: l’artista trae dalla realtà l’idea, poi con la sua opera ci fa capire la realtà.
Questo formidabile espediente rende il Mito una narrazione “senza veli” che gode della libertà superiore propria dell’atto artistico. Attraverso la finzione letteraria e per similitudine, il Mito può toccare le corde più intime e nascoste delle vicende umane, senza generare scandalo perché si parla degli dèi e non degli uomini.
La narrazione letteraria gode di una libertà sconfinata perché si sviluppa sul piano mentale e può costruire nell’immaginazione del lettore gli scenari più sontuosi e complessi, tanto non costa nulla.
Con la fotografia è molto più difficile produrre una narrazione per immagini attinente al Mito, proprio per la natura fantasiosa del tema. Per “Le Gru” è stato come realizzare un film ispirato a un romanzo; come nel cinema è stata necessaria la regia per coordinare l’ideazione e la realizzazione delle immagini, inevitabilmente attraverso la finzione. La finzione fotografica si compie grazie all’artificio, che può essere di natura: scenica o di grafica digitale. Indipendentemente dalla tecnica, la finzione è “l’immagine di un’idea” che parla al mondo delle idee con icone che accendono l’immaginazione nel lettore. Sono immagini che vanno oltre l’illustrazione spingendosi nell’interpretazione della trama letteraria. Le icone hanno come soggetto quel che detta il testo ma si avvalgono della forza narrativa propria dei messaggi sensoriali dell’immagine tecnica. L’effetto è quello di attenuare lo stile didascalico e amplificare quello emozionale, con il chiaro/scuro, i contrasti, lo sfuocato, il mosso, le doppie esposizioni, gli inserimenti digitali. Il racconto fotografico diventa la traduzione creativa del racconto letterario. Da questa autonoma capacità di narrare con la sequenza di immagini, veniamo a contatto con l’originale funzione culturale e morale del Mito che dal ”altrove divino” ci pone di fronte alle realissime conseguenze delle concrete scelte umane. Di certo, i fotografi de “Le Gru” elaborando insieme il tema hanno compreso significati e provato un complesso di sentimenti con i quali hanno creato le scene giuste, anche grazie ai siti archeologici. Hanno così riscoperto le radici più profonde della loro “Sicilitudine”.
ILSE NON DEVE MORIRE
di Pippo Pappalardo (Critico fotografico – Docente FIAF)
Nel linguaggio corrente il mito mantiene l’interpretazione platonica del termine ed è usato nel senso di “finzione”, di “illusione”. Gli etnologi e gli storici delle religioni e delle letterature ne hanno, però, restituito un significato più autentico: non più un’invenzione fantastica da riferire ad una mentalità primitiva che cerca una spiegazione naturalistica prima ancora che storica; e nemmeno una semplice narrazione cosmologica; meno che mai di tipo teogonica o meramente eziologica.
Il mito è, invece, narrazione di una realtà (M. Eliade). Una realtà che si è formata attraverso accadimenti ed eventi concreti nei quali i protagonisti sono stati uomini e donne che, con esso, sono stati coinvolti e partecipi. Il mito, pertanto, qualunque sia la sua natura, parla di ciò che è accaduto, e l’esistenza del mondo è lì a provarlo. Se la funzione del mito – nelle civiltà tradizionali non ancora desacralizzate e depotenziate delle risorse spirituali – fosse quella di rivelare i modelli esemplari dei riti e delle attività umane significative, il mito, nel nostro tempo, riferirebbe le origini del mondo reale e di tutti gli avvenimenti primordiali in seguito ai quali l’uomo è diventato quello che è oggi, cioè un essere mortale, sessuato, organizzato in società, costretto a lavorare per vivere, seguendo certe regole. Questa evidente constatazione ha proceduto parallelamente con l’operazione di “demitizzazione” ovvero con la volontà di ridurre la narrazione mitica nei limiti della verità e della conoscenza storica.
Una legittima ambizione; che ha dovuto, però, fare i conti con la “materia” nascosta tra le pagine del mito e le analisi psicologiche della medesima.
Ci sarà pure una ragione se ancora ci appropriamo del mito per le connessioni con il nostro vissuto e con quelle del nostro territorio?
Proprio queste ragioni hanno cercato i nostri amici, avendole intraviste ed intercettate peregrinando “tra le cose di Sicilia e la loro sicilitudine”.
Cosa hanno incontrato i loro occhi? Forse quel teatro che Ilse racconta agli Scalognati del mito pirandelliano dei “giganti della montagna”? Si, proprio quel teatro; che trapassa tra la scena del tempo delle stagioni e quello della “caverna” (altro mito, Repubblica, Platone) laddove il mondo conoscibile è limitato agli oggetti che ci circondano.
Quel teatro che ci parla con le maschere ambigue del sacro e del profano, guidandoci verso un desco quotidiano come verso una scacchiera. Quel teatro che, tra i campi arati e le onde instancabili, ci suggerisce l’immagine del labirinto o la spirale di una conchiglia come scena di una eterna sfida dove non c’è Dedalo a risolvere l’enigma o l’hybris di Icaro, ma occorre seguire una formica, o il filo d’Arianna. Proprio un filo, perché abbiamo bisogno della “corda pazza”, per uscire dall’insicurezza e penetrare, capire, la nostra sicilitudine.
E poi, perché la poesia non può, non deve morire.
Bibliografia:
- Mircea Eliade, Miti e società, Rusconi;
- Platone, Repubblica, Laterza.
- Pirandello Luigi, Il berretto a sonagli, Mondadori;
- Pirandello Luigi, I giganti della montagna; Mondadori
-
Sciascia Leonardo, la corda pazza, Einaudi
Autori:
G. Amenta, S. C. Auteri, P. Barbagallo, N. Bellini, A. Bottino, D. Cannavò, F. Cannizzaro, M. Caramanna, A. Costa, G. Cuscunà, S. Cuscunà, A. e L. D’agata, P. Ferlito, G. Fichera, S. Galvano, E. Massimino, G. Miano, S. Mongioì, S. Nicolosi, R. Pantò, R. Salvia, D. Sidari, V. Sorbello, S. Surrentino d’Afflitto, M. Torrisi, G. Zaberto.